La Malapianta - Un mondo magico e disperato
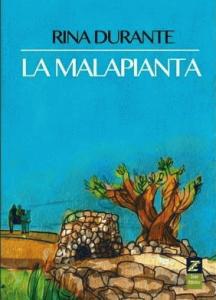
di Francesco "Lillo" Guadalupi*
Una «periferia infinita dall'atmosfera sonnolenta di una provincia stregata dal suo passato». È così che Rina Durante descriveva l'entroterra salentino in cui, negli anni Quaranta, tra Melendugno e Calimera, si muovono i personaggi de La malapianta. «Un popolo di contadini e braccianti — continua l'autrice — apparentemente povero e ignorante, ma che in realtà affonda le sue radici in una cultura spaventosamente ricca e complessa dando luogo a uno straordinario repertorio di immagini e suggestioni». Ed è proprio da questa violenta contrapposizione che scaturisce l'imponente visionarietà de La malapianta: in un clima assopito e alienante, di disperata resa alla vita, s'insinuano i laceranti percorsi esistenziali dei membri della famiglia Ardito, eternamente fluttuanti fra sogno e realtà, lucidità e pazzia, in una danza estenuante dalle cadenze ancestrali. Sono infatti esistenze, le loro, che si avvitano su se stesse in un moto sfibrante e ossessivo, senza possibilità di sfuggirvi, di deviare, di trovare un salvifico riscatto.
«Basta muoversi, basta agire in un modo qualsiasi ed ecco che tutto si muove attorno a noi e ci inghiotte» afferma Giulia paragonando la voglia del fratello Antonio «di fare qualcosa», che gli è valsa soltanto la morte in battaglia, all'ambigua titubanza del suo amante, don Armando, che lo condannerà per sempre ad essere un uomo «quieto e senza vita, come gli altri», un uomo dagli «occhi consumati da ciò che ha visto sino ad oggi». Pensando invece all'indolenza di suo padre, la ragazza si sfogherà rassegnata: «Che posso fare contro tutti? Se uno si mette in testa che non vuoi vivere, come gli si può dire "alzati e cammina"?». Si tratta di un'inettitudine alla vita, la simbolica "malapianta" appunto, che attecchisce nelle profondità dell'io ottundendone i sensi, ampliandone il distacco dalla realtà fino a proiettare i protagonisti della storia in una dimensione arbitraria e nebulosa. «Sembra una giornata lunare, tutto è slontanato e irreale» dice a un certo punto Luisa, una delle figlie, rintanata a casa con gli altri in una giornata piovosa, «il giorno è una bocca che c'inghiotte, piena di nebbia e di sogno, e il vino ci rende stolidi e allucinati in questo dormiveglia [...] penso e ripenso alla parola mondo, tutto il mondo, fine del mondo, l'altro mondo; penso e ripenso a questa parola sconcertante e mi gira la testa [...] il mondo è un mare d'inchiostro che ci inghiotte tutti». E ai confini del sogno si spingono i ricordi del fratellino Luigi quando scava nella sua prima infanzia e ne rinviene vacue immagini di «un'altra mamma», ma «forse l'ho sognato» conclude poi, liquidando di botto la faccenda.
Fra i contorni idilliaci e sfuggenti di un sogno si dibatte anche il ricordo che Gino serba della ragazza Seggiola, conosciuta per caso un giorno durante la raccolte delle olive e da quel momento divenuta un'ossessione che lo spingerà alla sua instancabile ricerca: il ragazzo, folgorato da quell'incontro, si chiederà se non fosse stato solo il frutto della sua immaginazione «dal principio alla fine». La "baronessa", dal canto suo, vive nel perenne ricordo delle figlioletta morta anni prima e cerca vanamente di rivederla viva e vegeta davanti a sé in un'atmosfera grottesca e surreale. Sul filo di un'analoga follia si dipanano le vicende della signora Caroli, preda di attacchi isterici e in perenne fuga da casa sotto lo sguardo attonito e sconsolato dei familiari, costretti ogni volta a mobilitarsi in suo soccorso. E lo stesso Gino, tornato dalla guerra, pare immerso in una sorta di intorpidimento dei sensi in cui affiorano vividi, a sprazzi, gli episodi vissuti sul campo di battaglia.
Rina Durante, all'epoca poco più che trentenne, dipinge questi spaccati di vita con una scrittura ariosa e vivace, passando dal registro più basso della cruda esistenza al più alto diapason dell'intensità lirica. «Io sono una scrittrice, — diceva di sé, — una raccontatrice, il mio mestiere è narrare, raccontare», spiegando come il suo interesse per la cultura e le tradizioni locali non avesse nulla di "accademico", di "scientifico", ma le servisse soltanto per assorbire storie, immagini, fatti e personaggi da asservire alla sua vocazione di narratrice. «Io non sono una ricercatrice, io sono moderatamente antropologa al servizio di qualcosa che non ha niente a che vedere con l'antropologia». Ossia la scrittura, sua passione ardente e mai sopita: «scrivere è un piacere che non può mai venir meno» dichiarò una volta alla stampa. La narrazione de La malapianta è di tipo "corale": la voce narrante in terza persona si alterna alla prima persona dei diversi personaggi che a turno prendono la parola.
Questo punto di osservazione continuamente mutevole consente all'autrice di esplorare con maggior rigore l'universo emotivo e i turbamenti di ogni singolo, conducendo il lettore a un passo dalle vibrazioni più intime e profonde dell'animo umano. Rina Durante attinge così al suo ricchissimo bagaglio di esperienze fatte "sul campo" con ingorda curiosità tracciando le coordinate di valori e sentimenti universali. Gli strazianti tormenti amorosi ad esempio, che si alternano a lampi di speranza e delusione, euforia e amarezza, vengono descritti con impressionante realismo e "cognizione di causa": i desideri contraddittori che legano Giulia e don Armando, la passione di Gino per Seggiola, la relazione tra Rosa e Niceta, l'amore incestuoso fra Antonio e la sorella... situazioni e stati d'animo che da sempre investono l'umanità, con tutta la loro irruenza, in ogni tempo e in ogni luogo. E a far da sfondo a tutto ciò vi è sempre quella perenne, frustrante incapacità di vivere, di affrontare una vita responsabile e matura, perché la vita inevitabilmente «ti si rivolta contro e ti divora», come dice il capofamiglia in un'amara riflessione sulla sua esistenza.
È una malapianta che germoglia lancinante dall'interno aggredendo l'organismo come i morsi della fame, fino a rendere tutto scialbo e insapore e a risucchiare qualsivoglia impulso vitale. Tanto che Rosa, agli occhi della figlia Marta, che finalmente prende coscienza della drammatica situazione familiare, appare come una donna indolente e arida, che tende a «modellarsi sulle cose, senza traumi». La fame è una presenza abnorme, oscura e inquietante che incombe, come un'antica divinità di morte, sulle esistenze dei personaggi nel corso di tutto il romanzo, e ognuno la vive a modo suo e ne viene plasmato in una maniera del tutto particolare. Rosa riesce in un primo momento a farci l'abitudine giungendo a limitare il dolore soltanto alla contemplazione della fame altrui, poi, quando il marito va via di casa, ritorna a soffrirla atrocemente e comincia a scagliare il suo rancore contro chiunque le capiti sotto tiro. Luisa teme che il fratello le parli della fame che sente. L'esistenza di Marta, invece, viene completamente annichilita dalla fame, che trasfigura il mondo circostante e si appiccica alla sua persona rendendola «malata e insufficiente», schiacciata da un senso di colpa che si fa ancora più opprimente allorché fa il confronto con la vita di Eugenio, lui sì «vivo, libero, puro».
È un tragico senso di inadeguatezza che l'autrice del romanzo descrive con estrema maestria e delicatezza, e tuttavia in una cifra stilistica vibrante e appassionata. Marta sente che questo "fiato maligno" non la abbandonerà mai e non le permetterà di salvarsi. Anche suo padre, chiamato in famiglia col nomignolo di Tela, si sente gravato da siffatta malasorte e sa che dovrà sopportarne le pene fino alla fine. «Sono incatenato alla morte — dice — ma per raggiungerla non c'è che da percorrere questa strada maledetta che vorresti scavalcare con un solo balzo, magari mettendoci tutta la forza che ti rimane. E invece te ne rimane sempre dell'altra e tu ci riprovi e te ne avanza sempre. Vuoi dire che si deve arrivare sino in fondo, in un modo o nell'altro», e dentro di sé impreca contro una prole nata suo malgrado. Teta: uomo dagli «occhi sottili come due tagli, stretti sulla verità», uomo dall’inconfessato amore per la sua terra che manda un «odore caldo e rassicurante, antico e lacerante come una ferita.. un lungo mormorio, triste e desolato». È un legame controverso e tormentato che finisce per impregnare la vita delle classi subalterne di un paese, com'era allora l'Italia, a prevalente economia rurale.
Il romanzo de La malapianta, d'altronde, è pura espressione del neorealismo, un movimento culturale fiorito nel dopoguerra, quando si fanno sentire prepotenti le istanze di una letteratura "impegnata", che aiuti a prendere coscienza della situazione contemporanea e che rinviava a sua volta alla grande narrativa realista dell'Ottocento. È un'esigenza che viene percepita a livello europeo di fronte ai drammatici avvenimenti di quegli anni e che chiama in causa lo status dello scrittore, un intellettuale che finalmente esce dalla sua "torre d'avorio" e si pone al servizio della società civile fornendo un megafono ai ceti sociali più umili ed emarginati. «Noi avevamo un intento che era politico, — scrisse Rina Durante — studiavamo la cultura popolare alla luce di questo interesse politico sui canti di lotta, sui canti di lavoro. La nostra riproposta aveva il fine di suscitare interesse verso il mondo popolare e la sua possibilità di riscatto. Un paese ha la sua storia e deve tenersela stretta, altrimenti perde la sua identità, che non può ridursi al dato etnico».
In quegli anni la militanza degli intellettuali si manifestava in un proliferare di iniziative letterarie e in senso lato culturali, di qui il nascere di alcune riviste sulle quali condurre il dibattito e trasporre la propria visione della realtà. La rivista più importante che "inaugurò" questo fenomeno fu «II Politecnico» (1945-1947) di Elio Vittorini, che aveva un'apertura di interesse internazionale; seguirono poi «Botteghe Oscure», «Paragone», «Officina» e via dicendo, che iniziarono ad accogliere le nuove tendenze letterarie. Lo stesso Vittorini fu insieme a Cesare Pavese tra i più influenti collaboratori della casa editrice Einaudi di Torino e diresse un'importante collana di narrativa, "I Gettoni", in cui furono pubblicati molti capisaldi della narrativa contemporanea, espressione delle diverse istanze che andavano via via emergendo in campo letterario. Dalla metà degli anni Cinquanta, infatti, i miti del neorealismo ricevettero i primi scossoni dovuti alle esigenze di una sperimentazione linguistica ritenuta ormai ineludibile. Fu in questo clima che la giovane Rina Durante si impose come voce "nuova" diventando, nella seconda metà del Novecento, figura fondamentale nel mondo culturale e letterario, nella vita sociale e nella riscoperta e valorizzazione delle tradizioni popolari. «Fare il poeta, ma anche lo scrittore, è faticoso, — affermò — perché è una grande fatica trovare la verità di tutti, ma ancora di più dirla a tutti in un mondo che rinuncia al proprio volto, che fa di tutto per massificarsi. Il poeta, oggi, ha questo dovere di deludere, gridando alta la sua verità».
Sosteneva che "l'uomo folklorico" fosse erroneamente considerato un individuo avulso dalla storia, una sorta di "buon selvaggio". Ma si tratta di una convinzione sbagliata e riduttiva, ammoniva Rina Durante, perché non tiene conto della storia «che tutto macina» finendo per travolgere «anche il povero cristo senza potere né speranza di riscatto, e lo investe e lo coinvolge e lo trasforma». Sono momenti di presa di coscienza determinanti «in cui il buon selvaggio alza la testa, scende in piazza ed entra nella Storia», momenti che, — diceva, — bisogna andarsi a cercare, a reperire accuratamente. I personaggi de La malapianta interagiscono proprio in questo convulso mondo di miseria lacerato dalle contraddizioni e da una disperata, e spesso fatua, voglia di rivincita. «C'è un modo di franare stando in piedi, diritta e tranquilla — afferma Luisa in uno dei passi più magistrali e toccanti del libro — con gli altri intorno che ti guardano e sono tranquilli anche loro del tuo modo sempre uguale di tenerti su, senza scosse e cambiamenti. Ed è in quell'istante preciso che tu te ne sei andata, e hai detto loro addio con tutte le tue forze, senza dire una parola, pur sapendo di franare là dove nessuno di loro saprà più ritrovarti».
Un'ombra tetra e opprimente grava, dall'inizio alla fine, su ogni pagina del romanzo, che termina tuttavia con una inaspettata e spiazzante nota di speranza: simboleggiata dall'imperioso fascio di luce primaverile che entra dalla porta aperta da Luigi inondando la stanza e ammantando ogni cosa. La promessa di un'abbagliante palingenesi, di un insperato, liberatorio riscatto finalmente sbocciato.
*Postfazione alla seconda edizione de La Malapianta (Zane, 2014).